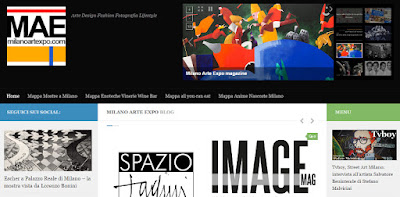|
| Bernadette |
Bernadette Soubirous di Franz Werfel, da
Lourdes al
romanzo. La Nostra è la protagonista del romanzo
Il canto di Bernadette di F. Werfel (1890 – 1945). Esso si ispira alla figura di Bernadette Soubirous (1844 – 1879), la pastorella di Lourdes a cui la Vergine, sotto l'aspetto di una signora bellissima, apparve ripetutamente nella grotta di Massabielle. Questo personaggio di Franz Werfel attesta un'acuta intuizione dell'elemento affine che ricollega il mondo religioso a quello artistico. In più punti dell'opera ci sono precisi richiami a questa vaga analogia.
 |
Bernadette Soubirous,
grotta di Massabielle,
foto del 1863 |
Con cauto linguaggio che evita un deciso atteggiamento razionalistico Franz Werfel osserva una volta: "a
lla piccola Bernadette è riuscito ciò che riesce soltanto ai più grandi poeti: quello che i suoi occhi vedono per grazia del cielo, circola fra la gente del suo popolo come una realtà". Ecco una considerazione che spiega il rapporto tra il fatto religioso e la creazione artistica. L'autore insiste sempre sulla immaginazione estremamente vivace di Bernadette, sulla sua innocenza del tutto candida, sul suo stupore di qualità estatica. La mente della fanciulla è chiusa alle speculazioni astratte. Quando suor Marie-Thérèse Vauzous la interroga sulla Santissima Trinità, Bernadette, che è la maggiore ma la più immatura della classe, non sa che cosa rispondere. La parola presepio, però, esalta subito la sua fantasia che evoca l'immagini nitide e pittoresche.
La prodigiosa forza spirituale di Bernadette dipende dalla perfetta fusione di una immaginazione fervida con una fede vigorosa. L'agente delle imposte, Estrade, "non riesce a comprendere la strana potenza con la quale questa ottusa figlia dei Pirenei con ogni suo sguardo, ogni suo passo, ogni suo gesto, dà vita e realtà a ciò che non esiste". Il segreto di tale potenza e la intensità della sua vita interiore. La realtà si identifica per lei in un impulso d'amore verso la misteriosa e bellissima
Nostra Signora di Lourdes. Bernadette non indaga mai chi sia, né si domanda dei perché: lei vive, ama, gode. La fiamma la trasfigura anche fisicamente. La madre, dapprima incredula e sordamente irritata contro la figlia che le procura, col suo estatico contegno, molte noie, osservandola durante un'apparizione, esclama: "quella non è lei… Quella non è Bernadette… Non riconosco più la mia bambina…"
Gli incontri con la Signora mutano poco a poco il suo aspetto esteriore. Indifferente a tutto, lei è sensibilissima e risoluta nell'ambito del suo mondo: di fronte alla Bellissima, la sua indomita volontà si esplica, si intende, unicamente sotto il rapporto che intercorre tra la più eccelsa imperatrice e la più umile ancella.
Bernadette trapassa dall'estasi al languore, al deliquio. Un accenno di benevolenza da parte della Signora la esalta, il sospetto della sua disapprovazione da abbattere: la vicenda di questi sentimenti non altera solo l'anima, ma anche il corpo, tanto grande è la tensione di Bernadette. Essa agisce come guidata da voci interiori, i suoi gesti acquistano una solennità rituale, anche negli atti più comuni: un segno di croce, la recita della preghiera, un inchino.
A volte Bernadette e si trasferisce (in modo inconsapevole) in quella fase primordiale - per così dire mitica - in cui il culto spontaneamente nasce, come quando è la bacia la terra per esprimere la soddisfazione di aver capito la Signora. "Era un cerimoniale che avvicinava spiritualmente al divino con tale potenza che al suo confronto una solenne messa cantata diventava una vuota pomposità".
Sgombra d'ogni superbia e vanità, la sua mente va diritta al segno. "La sua logica, poggiata sulla potenza persuasiva dell'amore" confuta i dotti, laici e religiosi. L'alone mistico che avvolge la sua umiltà diffonde la luce della grazia
e crea l'aura del miracolo. Pur turbato, di quando in quando, da incubi terribili e fantasmi diabolici, il suo spirito si eleva in ultimo alla pura letizia, trionfa a poco a poco sullo scandalo, sull'irrisione, sull'odio, sulla miscredenza, e la sua gloria sale man mano dal tugurio paterno alla grotta di Lourdes, al convento di Sainte-Gildarde, per sfolgorare nella solenne cerimonia della santificazione in San Pietro.
Franz Werfel segue con mirabile perspicacia intuitiva i vari atteggiamenti psichici del personaggio Bernadette che resta sempre sospeso in una zona di confine fra la fiaba poetica e la leggenda sacra, conservando però i tratti di una creatura storica.
La verità artistica della figura dipende da un sapiente equilibrio di elementi eterogenei, proiettati sopra uno sfondo remoto tanto dalla introspezione psicanalitica quanto dall'oratoria edificativa.